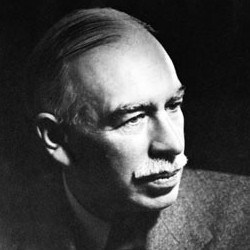 Riceviamo e pubblichiamo il contributo di Maria Romana Mongiello, dottore in Economia Europea, socia dell’associazione politico-economica “Viaggiatori in Movimento”
Riceviamo e pubblichiamo il contributo di Maria Romana Mongiello, dottore in Economia Europea, socia dell’associazione politico-economica “Viaggiatori in Movimento”
Primogenito delle disuguaglianze sociali e culturali, nasce e cresce in un contesto di austerità, speculazione e corruzione.
di Maria Romana Mongiello
Nel febbraio 2012 il Financial Times pubblicò una lettera di noti economisti, tra cui Marcello De Cecco, che a gran voce incitava insieme a Paul de Grawe la riduzione delle pressioni di pareggio di bilancio e delle misure di austerità per i paesi sprofondati in recessione. Tutto questo per la salvaguardia della famigerata zona euro.
Oggi, a distanza di due anni, quali sono stati i cambiamenti? Possiamo affermare che, tra il malcontento dei cittadini e l’instabilità del nostro governo, la richiesta a livello comunitario sia stata comunque soddisfatta? Siamo usciti o stiamo uscendo dalla tunnel recessivo?
Una recessione che per i politici di Francoforte è la peccaminosa conseguenza di aver condotto la spesa pubblica nei meandri dell’assurdo ed al confine con l’insostenibile. Diversamente da quanto affermò il giornalista Raffaele Vignali “non è tutta colpa di Keynes” e rispondendo al saluto posto da Franco Reviglio in “Goodbye Keynes”, sembra che anche per Papa Francesco, rappresentante di uno stato libero per natura, l’iniquità sociale ed un’economia basata sul principio dell’esclusione figurino tra i primi massi da sollevare per liberare la strada che conduce al benessere di tutti. Premesso che possa essere quantificato un limite superiore del debito pubblico per poter dichiarare insolvente uno Stato, non si deve escludere che coesista allo stesso tempo un limite inferiore, oltre il quale una riduzione dello stesso, accompagnata dalla costante presenza di un basso (o quasi nullo) tasso di crescita ed un aumento considerevole del livello generale dei prezzi, portino l’ economia verso la depressione. La Teoria keynesiana dunque solleva il dibattito, oggi divenuto politico, della scelta tra liberismo e interventismo economico. L’interventismo promosso da John Maynard Keynes non è eccesso di regolamentazione, come i critici potrebbero sostenere, ma appare più che altro il giusto prezzo da sopportare per non essere al di sotto della piena occupazione, appurato che non esista un mercato del lavoro così flessibile da non pregiudicare l’incontro tra la domanda e l’offerta. Egli afferma nella Teoria Generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta che “i difetti lampanti della società economica in cui viviamo sono la sua incapacità di provvedere alla piena”occupazione e la sua distribuzione arbitraria e iniqua della ricchezza e dei redditi”. Uno stato premonitore e non cieco, garante delle situazioni di diritto che il sistema economico da solo non riesce ad offrire. Uno stato equo e solidale, non corrotto e non eccessivamente severo, appare l’ unica ricetta per uscire tutti dallaGrande Crisi. L’analisi keynesiana concentra la sua impostazione teorica sulla stimolazione della domanda globale con variazioni della spesa pubblica, che in un certo senso favoriscano la stabilizzazione congiunturale ed il pieno impiego delle risorse. Il rafforzamento di tale assunzione proviene dal capovolgimento delle ipotesi classiche secondo cui sia il risparmio a generare gli investimenti; Keynes spiega che, nei momenti di crisi, il settore privato sarà spinto al disinvestimento e aggraverà viziosamente la già precaria situazione economica. Lo Stato, a costo di andare in deficit di bilancio, potrà programmare di effettuare spese in opere pubbliche, specie in infrastrutture, sanità ed istruzione. Egli ritiene indispensabili le strutture intermedie semi-autonome (Università, Banche Centrali, associazioni, corporazioni, sindacati) che operino secondo i principi democratici e parlamentari tra l’individuo e lo Stato centrale, in modo tale da assicurare quel livello minimo garantito a tutti di bene pubblico (non rivale e non escludibile). L’ intervento pubblico in deficit di bilancio è giustificato dalla presenza cronica della disuguaglianza sociale, già mnzionata nel phamplhet del 1926 intitolato La fine del laissez-faire, dove Keynes rievoca il tema centrale dell’equità rispetto all’uguaglianza, criterio prevalente nei mercati concorrenziali, in cui la competitività spinge verso un benessere che “salva” e predilige chi possiede più dotazioni fattoriali e strumenti per resistere alla selezione naturale. L’ autore si serve della metafora delle giraffe a collo corto, ormai “selettivamente” eliminate dalla natura animale e si pone l’interrogativo di quanto sia etico e socialmente accettabile che lo stesso accada in una civiltà amministrata da umani, che agiscano per mezzo di sistemi legali ed economici alla base di costrutti ideologici e non naturali. Ma non è quello che si sta verificando nelle nostre pagine di storia. I sacrifici che l’austerità europea, insita nei vincoli e nelle regole di partecipazione, costringe a fare propugnano l’idea che parte di questa crisi sia dovuta all’ingente debito pubblico prodotto dai paesi nel secolo scorso, risultato per alcuni di una spesa pubblica esorbitante ed eccessiva e dunque di politiche keynesiane. Se un aumento della spesa pubblica dovesse andare a discapito della crescita e ripercuotersi in situazioni malsane di gestione della cosa pubblica, allora perché ci sono realtà economiche in cui un alto debito pubblico è accompagnato da un consistente tasso di crescita? E qual è l’elemento impedente affinché ciò si riscontri in tutte le economie? cosa farà un normale imprenditore – immaginando una situazione in cui si trova a scegliere tra il dover chiudere la propria azienda o trovare finanziamenti per ristrutturare gli investimenti? Chiederà un prestito alla banca di fiducia, che in garanzia vorrà una casa o parte del patrimonio aziendale, oppure venderà ad un prezzo di mercato bassissimo al primo offerente la propria azienda? Razionalmente parlando, la seconda scelta non rientra nelle sue volontà ed ammettendo anche che decida di vendere, sapendo che di rendita non si vive, si troverà senza lavoro ed a quel punto dovrà cercare o un impiego dipendente (estremamente utopico!), ma nel caso in cui volesse riaprire una nuova attività e sperimentare un nuovo settore, avrà comunque bisogno di finanziamenti. Lo stesso accade per uno Stato, esso non vive di rendita e per crescere deve continuamente innovare la struttura dei suoi investimenti. Affermare che lo Stato non debba percorrere la via dell’indebitamento, significa porre un limite ad investire su se stesso. Così uno Stato non sarà capace di affrontare crisi e periodi di difficoltà senza la possibilità di sostenere l’apparato economico sociale in cui si riflette nella sua essenza, quale aggregazione di agenti e collettività. La teoria keynesiana nasce e muore in un orizzonte di breve periodo, il che porta a credere che non sia lo stesso Keynes a parlare di aumento di debito pubblico (variabile che per sua natura deve contestualizzarsi al lungo periodo), quanto piuttosto di uno stimolo della domanda aggregata attraverso l’iniezione temporanea e non continua di spesa pubblica, il cd moltiplicatore keynesiano.
Ci potrà essere un deficit di bilancio? Bene, esso sarà ricoperto con le future entrate derivanti dalla tassazione, direttamente dipendente dal reddito che aumenta vertiginosamente quando anche i disoccupati trovano un posto nel mondo. Keynes non ha mai parlato del protrarsi di una situazione di squilibrio di cassa pubblica, ma delle le sue interpretazioni politiche e di quelle di chi lo ha fatto. Non a caso Scognamiglio afferma «che Keynes era meno keynesiano di quanto si possa immaginare».
Perché allora questa Germania e questa Europa ci chiedono di non mangiare non un altro euro di spesa pubblica? Per paura, forse, che lo stato non ingrassi a sufficienza?
Nel settore pubblico però non esistono “magri per natura”. Quando si sta a tavola ci si sazia e quando non è abbastanza vuol dire due cose: o che la cucina non era di pregiata qualità, o che si è preferito far mangiare l’ospite chiamato corruzione. Entrambe queste situazioni portano qualsiasi banca a non fidarsi, dunque meglio rischiare di essere eccessivamente severi, razionando il credito, che incorrere in una clientela negligente e disonesta. La nostra storia non è tra le migliori garanzie che possiamo offrire all’Europa.
Il moltiplicatore keynesiano, strumento di breve periodo per risollevare da situazioni di generale sfiducia e impasse economico, esiste come tale solo fino a quando non ci troviamo in presenza di corruzione ed elevati problemi strutturali, per i quali il tessuto culturale sociale fa la parte maggiore. Recentemente è stato studiato da chi scrive il divario regionale esistente tra il Mezzogiorno e il Settentrione Italiano, comparando gli effetti del moltiplicatore e le cause delle divergenze. I fattori che spiegano maggiormente un reale divario sono l’ internazionalizzazione ed il capitale sociale strettamente connesso all’università, rifratto della speranza che il titolo di studio possa garantire o essere un salvagente all’elevata disoccupazione. Il basso grado d’istruzione e del livello culturale viene giustificato dai dati relativi alla criminalità minorile, che per lo più è bassa laddove vi è un potere attrattivo dell’università alto e viceversa, con eccezioni assimilabili a fattori esogeni quali l’isolamento territoriale, le caratteristiche culturali e storiche locali. I valori troppo alti per le regioni a ridosso della punta e del tacco dello stivale, giustificati anche dalla propensione al consumo alta, esplicano da una parte la strozzatura dell’economia bisognosa di risorse e di maggiore autonomia nel produrle (il grado di dipendenza è il doppio al Sud rispetto al Nord); e dall’ altra la maggiore qualifica di queste ultime (la propensione agli investimenti risulta similare). La perdita di qualità potrebbe essere la somma dei singoli comportamenti convenzionali keynesiani viventi nel familismo amorale disegnato da Banfield, dove in una permanente assenza di morale pubblica, i principi e le categorie del bene e del male rimangono, ma vengono applicati solo ed unicamente nell’ambito dei rapporti di sangue, dove il clan familiare si sostituisce nell’ offerta di beni e servizi pubblici. Si perde così il fine keynesiano del governo, definito da un grado socialmente raggiunto di felicità generale, equità e benessere.
I vincoli europei servono proprio ad evitare che si entri in una spirale – aumento della spesa pubblica, corruzione e sprechi-aumento del debito – quando invece si potrebbero inasprire le misure di controllo e sanzionatorie nei confronti dei debitori inadempienti e permettere comunque ad un paese come il nostro una certa flessibilità di bilancio, soprattutto in presenza del veto per le politiche di svalutazione (in presenza di moneta comune non possiamo svalutare per recuperare competitività). Altrimenti, l’unica via da perseguire sarà la politica fiscale comune, che comporta per paesi come la Germania l’assolvimento di responsabilità in termini di sussidi e trasferimenti ad altre economie come la nostra, una realtà che fino ad oggi rientra al massimo nella fattispecie di interventi solidali e dovrebbe rientrare nel collettivo comune agire. Non è eliminando il problema ab origine o negando che una soluzione vada presa (e anche repentinamente) che si riuscirà a toccare terra ferma in un mare di disoccupati: se il terreno delle nuove prospettive d’ investimento privato rimane infertile e secco, su qualcuno dovrà pur gravare il dovere di innaffiare, altrimenti anche se l’Europa fa finta di non saperlo, come in una sorta di osmosi, sarà lei stessa a pagare il disinteresse per le disuguaglianze. Perché le disuguaglianze sono situazioni che, se trascurate nei cicli, spesso figurano tra le cause principali delle recessioni: trascurarle in recessione, dunque , vorrebbe dire aggravare ancora di più i costi che questa comporta. Ed ecco perché lo stesso Keynes in una lettera al Presidente degli Stati Uniti F. D. Roosvelt nel 1937 scrive «che il momento giusto per l’ austerità al Tesoro è l’espansione, non la recessione». Ma la piega rigida e austera non è solo il riflesso di paure, ma anche il retaggio della finanza speculativa che spinge verso un incremento sempre più veloce dell’economia finanziaria a discapito dell’economia reale (nell’esempio precedente il nostro imprenditore, se impossibilitato ad investire, potrà solo che depositare i propri risparmi in banca, peggio ancora se estera). Motivo per cui Luca Fantacci parla di fine della finanza. Il fenomeno delle disuguaglianze dovrebbe preoccupare non solo l’interesse pubblico quindi, ma anche quello privato e “dei poteri forti”, perché esse alimentano stress tra i tassi di interesse nominale ed i valori di borsa. Più il mercato monetario mangerà una fetta del mercato reale, più la finanza perderà la sua funzione originaria, quale intermediario tra risparmiatori e investitori, trasformandosi da vaso comunicante in vaso costrittore con un successivo congelamento del sistema economico generale. Per il semplice ovvio fatto che il mercato monetario seleziona i propri agenti in base alle possibilità economiche, non per discriminazione razziale sia chiaro, ma per principi di competitività necessariamente basata sulla quantità di danaro in circolazione, ci sarà la conseguente morte del piccolo risparmiatore e l’inasprimento della disuguaglianza sociale. Quando, in un regno onesto e meno che corrotto, governi e banche avranno indossato le vesti di Robin Hood forse esisteranno giorni migliori di questi. Scenario che lo stesso Keynes aveva dato per scontato.



