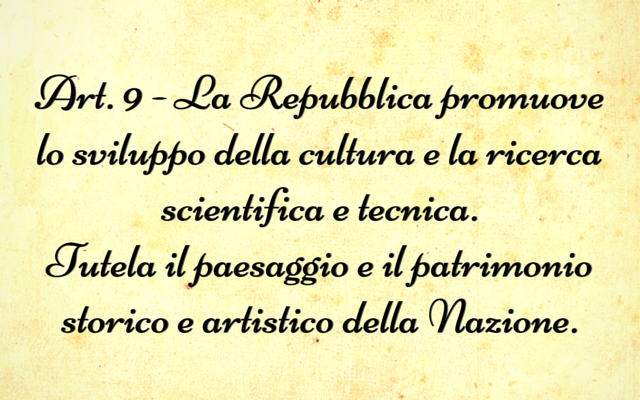Che il patrimonio culturale della Nazione sia bene comune è un concetto troppo spesso dimenticato. La conseguenza più vistosa di questo “vuoto di memoria” potrebbe facilmente essere additata nell’ingresso a pagamento nei musei statali. Utilizziamo il condizionale “potrebbe” perché, in realtà, la cultura della mercificazione del patrimonio porta a una collettiva levata di scudi contro quello che è un diritto dei cittadini, ovvero poter godere liberamente di ciò che è loro. Inserendo, infatti, il patrimonio nella Carta Costituzionale e tra i suoi principi fondamentali (art. 9), i nostri costituenti lo hanno legato indissolubilmente alla comunità.
Eppure ci si trova spesso a udire frasi del tipo “Bisogna pagare per vedere la nostra arte!” che presentano di per sé una grande contraddizione: la necessità di pagare per poter godere di ciò che è nostro. Per sradicare un concetto che la cultura del profitto ha imposto alla collettività che, senza accorgersene, lo ha fatto proprio a scapito di un proprio diritto, basterebbe ricordare la natura di “luogo della cultura” del museo. Nel 2006, l’allora Ministro per i Beni e le Attività Culturali Francesco Rutelli ha fatto pubblicare un volumetto, a distribuzione gratuita, dal titolo Italia: i luoghi della cultura, nel quale vengono passati in rassegna, dalla grande città al piccolo centro, tutte le istituzioni culturali presenti sul territorio nazionale: tra esse, assieme ai musei, laddove presenti, figurano anche archivi e biblioteche. Nessuno paga per accedere al patrimonio custodito in archivi e biblioteche, perché pagare per il museo che ha la stessa finalità di diffusione della cultura come i primi due?
La resistenza maggiore è, tuttavia, costituita da un’altra frase di circostanza: “E come si mantengono i musei?”.
La risposta più ovvia sarebbe: “Difficile che si possano mantenere se si continuano a fare tagli!”, ma proviamo ad andare oltre. Nel 1993, con la legge 4 (Legge Ronchey), approvata all’unanimità, si inaugura una stagione di apertura ai privati nella gestione dei servizi legati ai musei. I campi di applicazione di tale normativa – essenzialmente servizi di gestione e vendita di materiale legato ai beni culturali e ristorazione – sono andati ampliandosi in maniera tentacolare nel corso dei successivi interventi giuridici, includendo nella gestione indiretta anche le visite guidate, i servizi didattici e l’organizzazione di eventi all’interno delle strutture deputate, oltre alla possibilità di concedere in uso ai privati il bene stesso (art. 117 del Nuovo Codice del 2004 che, di fatto, manda in pensione la Legge Ronchey); nel 2009, inoltre, si è arrivati a “snellire” le procedure di affidamento dei servizi aggiuntivi in musei e istituti ministeriali. Il volume di affari di questi servizi aggiuntivi è notevole, ma allo Stato non spetta che una minima parte: basti pensare agli introiti da servizi aggiuntivi a Roma, nel 2013, pari a circa 17 milioni di euro dei quali solo 2 sono finiti nelle casse statali e 15 nelle tasche degli appaltatori.
Si comprende bene come, se questa gestione fosse statale o, almeno, la ripartizione degli utili fosse più proporzionata, la liquidità derivante dal servizio aggiuntivo in un museo concorrerebbe, in misura non trascurabile, a rimpolpare il bilancio del MIBACT; forse abbastanza da permettere l’abolizione del prezzo del biglietto nei musei e l’affermazione del principio per il quale l’accesso alla cultura debba essere per tutti e non soltanto per chi se lo possa permettere; e, perché no, garantire qualche altro posto di lavoro. Infatti, il servizio all’interno del museo, qualificandosi come aggiuntivo, comporta di per sé un prezzo, legato anche alla professionalità del personale deputato a fornirlo. Se si procedesse all’assunzione da parte del Ministero di personale qualificato anche per questi servizi, oltre a garantire un reddito agli operatori, si permetterebbe la limitazione dell’iniziativa privata all’interno della cosa pubblica, lasciando allo Stato una parte maggiore rispetto alla attuale degli introiti derivanti dai servizi. Ma molti musei, oggi, hanno difficoltà a tenere aperte le sale per carenza di personale e, in alcuni luoghi culturali, si fa ricorso al volontariato in sostituzione degli operatori del Ministero (la Legge Ronchey, invece, prevedeva che il volontariato affiancasse e non sostituisse il personale statale): ciò comporta, oltre a un fastidioso turn-over nell’apertura delle sale, anche la difficoltà, da parte dei custodi, di gestire momenti di grande caos come quelli che si verificano durante le aperture gratuite, quando la gente si riversa nei musei allettata dall’idea di non dover pagare il biglietto. Numeri da record che non servono a nulla se restano le difficoltà nella gestione delle orde di visitatori e, per gli stessi, quella di godere appieno del patrimonio tra una sgomitata e l’altra. Cosa che, verosimilmente, non accadrebbe se la gratuità (o, per lo meno, un prezzo popolare, tipo 1 euro) fosse la norma: non ha senso fare il boom di ingressi in un solo giorno per poi lasciare le sale – si parla dei musei meno frequentati – vuote il resto del mese: non c’è destinazione al museo degli introiti dei biglietti che tenga se la gente non vuole pagare per accedere al patrimonio. E’ una sconfitta culturale!
Tornando alla gestione indiretta, visti i numeri, Dario Franceschini annuncia che sarebbe il caso di far tornare i servizi, “almeno in un’opzione di scelta, alla titolarità pubblica”. Sarebbe meraviglioso! Ma il Ministro pare aver individuato già il soggetto che rappresenterà lo Stato: si tratta di Ales, società in house del MIBACT amministrata da Giuseppe Proietti, dal passato un po’ turbolento.
Che si tratti del solito colpo gobbo mascherato da Zorro? Staremo a vedere.
Intanto, restiamo in attesa di politiche culturali serie…
StecaS