 A seguito della fine del socialismo reale e della divisione del mondo in due blocchi, i paesi europei hanno abbracciato modelli economici di purissima derivazione neoliberista. Nonostante questa battuta d’arresto, le socialdemocrazie nordiche, in particolare quella svedese, non hanno mai perduto la naturale inclinazione a ben oculate sperimentazioni in materia di politiche del lavoro. Infatti, mentre in Italia il duo Renzi-Poletti prosegue in maniera indefessa l’opera di deregolamentazione della legislazione sul lavoro, dalla Svezia arriva una proposta di riduzione dell’orario di lavoro, aliena rispetto al contesto europeo.
A seguito della fine del socialismo reale e della divisione del mondo in due blocchi, i paesi europei hanno abbracciato modelli economici di purissima derivazione neoliberista. Nonostante questa battuta d’arresto, le socialdemocrazie nordiche, in particolare quella svedese, non hanno mai perduto la naturale inclinazione a ben oculate sperimentazioni in materia di politiche del lavoro. Infatti, mentre in Italia il duo Renzi-Poletti prosegue in maniera indefessa l’opera di deregolamentazione della legislazione sul lavoro, dalla Svezia arriva una proposta di riduzione dell’orario di lavoro, aliena rispetto al contesto europeo.
A Goteborg, seconda città della Svezia, governata da una coalizione formata dal Partito socialdemocratico, dal Partito dei Verdi e dal Partito della Sinistra, il vicesindaco Mats Pilehm, esponente proprio di quest’ultima formazione, ha avanzato una proposta per la sperimentazione della giornata lavorativa di 6 ore nel settore pubblico, con un totale di 30 ore settimanali, senza riduzione dello stipendio. Solo una parte dei dipendenti pubblici però beneficerà, per ora, dell’orario ridotto. Altri impiegati continueranno a seguire turni standard di 8 ore. Questa scelta del dipartimento di Goteborg, è dettata da una specifica finalità: favorire la riduzione delle assenze al fine di migliorare la produttività dei dipendenti. Si confida nel fatto che i dipendenti pubblici, lavorando meno, si assentino meno e possano essere fisicamente e mentalmente più efficienti.
L’idea della riduzione dell’orario di lavoro non è però una prerogativa svedese, ma una battaglia portata avanti da numerose forze di sinistra in tutta Europa, in particolar modo dai teorici operaisti italiani. A detta di numerosi studiosi, il motto “lavorare meno, lavorare tutti” è ancora sostenibile nell’attuale fase di recessione economica, con disoccupazione e precarietà galoppanti. La disoccupazione giovanile che colpisce l’Italia e altri paesi europei in una forma estremamente acuta è vissuta come una calamità naturale, un’emergenza, come se si trattasse di un incidente di percorso, di un evento imprevedibile della storia del capitalismo nei paesi industrializzati. Il fatto che la disoccupazione in generale, e quella giovanile in particolare, siano un dato strutturale nei paesi a capitalismo maturo non è nemmeno preso in considerazione nell’odierno dibattito politico.
Governo e parti sociali, di comune accordo, negli anni hanno progressivamente proposto e avvallato leggi che vanno diametralmente nella direzione opposta (Legge “Biagi”, Legge “Fornero”) e per ultimo il Job act di Renzi che precarizza ulteriormente il mercato del lavoro ed incentiva le ore di lavoro straordinario, allungando quindi il tempo di lavoro nell’arco di una vita. Il compito della politica e delle imprese è invece quello di rintracciare la nuova composizione degli effettivi bisogni dei cittadini-lavoratori. La riduzione del tempo di lavoro deve progettare nuovi scenari di lavori e rinnovati spazi di libertà individuale. Ad esempio, in Italia la riduzione dell’orario di lavoro potrebbe favorire una importante spinta verso una ripartizione della produzione tra i precari e i disoccupati.
Keynes pensava che, nel breve periodo, si potesse contrastare la disoccupazione con un incremento della spesa pubblica in deficit, ma che nel lungo periodo dovevamo fare inevitabilmente i conti con la disoccupazione tecnologica che l’inarrestabile progresso tecnologico avrebbe comportato. L’unica terapia efficace in grado di contrastare la crescente disoccupazione era, secondo l’economista di Cambridge, la netta riduzione dell’orario di lavoro. Nell’ultimo secolo, l’orario di lavoro è rimasto pressoché invariato nei paesi industrializzati, malgrado gli enormi aumenti di produttività che, come aveva previsto Keynes, hanno ridotto drasticamente l’energia umana per unità di prodotto. Nell’area dell’Unione Europea, gli straordinari aumenti di produttività sono andati in gran parte ai profitti ed alle rendite delle aziende, dato che la quota dei salari sul PIL è scesa drasticamente in tutti i paesi occidentali negli ultimi 20 anni.
Se solo ci fosse una reale volontà politica, si potrebbe concertare una riduzione significativa dell’orario di lavoro in tutti i settori di produzione e del pubblico impiego. Per esempio, con una riduzione di quattro ore di lavoro settimanale, a parità di salario, si potrebbe creare solo in Italia oltre un milione di posti di lavoro, tra pubblico e privato. Le imprese insistono invece per la defiscalizzazione degli straordinari. In questo modo, i precari ed i lavoratori sottopagati sono costretti a fare un secondo o terzo lavoro; nel contempo aumenta l’età pensionabile a causa delle ultime riforme. Di conseguenza, la disoccupazione cresce a dismisura: 2,2 milioni di giovani non studiano né lavorano.
Per contrastare la recessione e le politiche di austerity, oltre ad una ripresa della spesa pubblica – così come auspicato dagli economisti di ispirazione keynesiana -, la riduzione dell’orario di lavoro non è solo una necessità per contrastare la disoccupazione crescente, ma anche una scelta di civiltà. A cosa è servito lo strepitoso progresso tecnologico? Che senso ha una società che dopo aver moltiplicato per cinque volte la sua ricchezza materiale dopo la seconda guerra mondiale, non riesce a distribuire decentemente il lavoro e la ricchezza prodotta, costringendo alcuni a morire di lavoro ed altri a suicidarsi per la mancanza di lavoro? Il reddito minimo, inteso come diritto alla vita, può rappresentare una soluzione temporanea alla mancanza di lavoro, tuttavia non risolve il bisogno di un lavoro che dia alle persone la possibilità di esprimersi, di sentirsi socialmente utili e di avere un posto nella società.
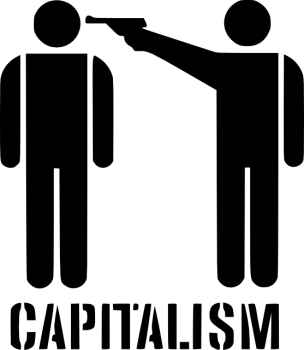 Negli ultimi anni, invece, abbiamo assistito ad un attacco violentissimo contro il salario diretto, indiretto e differito, ad un aumento dei ritmi di lavoro e ad una compressione dei diritti. Il nodo gordiano è sempre lì ad attenderci: quello del conflitto tra capitale e lavoro; perché c’è una incompatibilità radicale tra chi produce e chi beneficia della fatica altrui, tra chi è disoccupato e chi lo mantiene in standby per poterlo ricattare meglio, tra chi aspira ad entrare nel mercato del lavoro e costruirsi un futuro, e chi sceglie di tenerlo fuori in modo da far lavorare meno persone, ma sfruttandole più intensamente. Oggi è necessario riprendere la battaglia per il diritto al lavoro, a lavorare meno, a lavorare tutti, alla sicurezza e a parità di salario, perché chi sta “dentro” al mercato del lavoro non possa morire di fatica e chi sta “fuori” entri dentro e prenda parola, libero da logiche assistenziali, per incidere direttamente sulle forme di dominio.
Negli ultimi anni, invece, abbiamo assistito ad un attacco violentissimo contro il salario diretto, indiretto e differito, ad un aumento dei ritmi di lavoro e ad una compressione dei diritti. Il nodo gordiano è sempre lì ad attenderci: quello del conflitto tra capitale e lavoro; perché c’è una incompatibilità radicale tra chi produce e chi beneficia della fatica altrui, tra chi è disoccupato e chi lo mantiene in standby per poterlo ricattare meglio, tra chi aspira ad entrare nel mercato del lavoro e costruirsi un futuro, e chi sceglie di tenerlo fuori in modo da far lavorare meno persone, ma sfruttandole più intensamente. Oggi è necessario riprendere la battaglia per il diritto al lavoro, a lavorare meno, a lavorare tutti, alla sicurezza e a parità di salario, perché chi sta “dentro” al mercato del lavoro non possa morire di fatica e chi sta “fuori” entri dentro e prenda parola, libero da logiche assistenziali, per incidere direttamente sulle forme di dominio.



